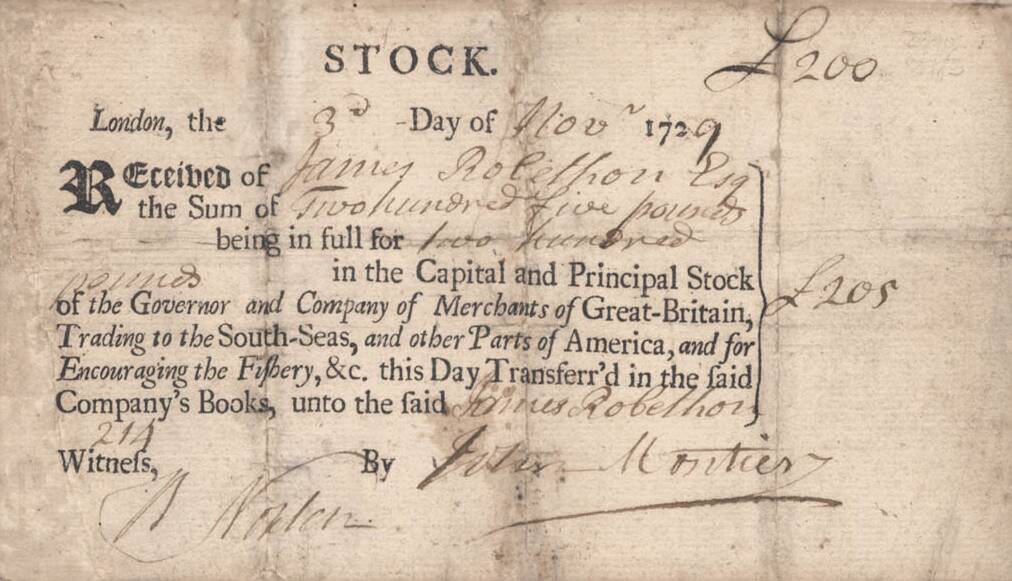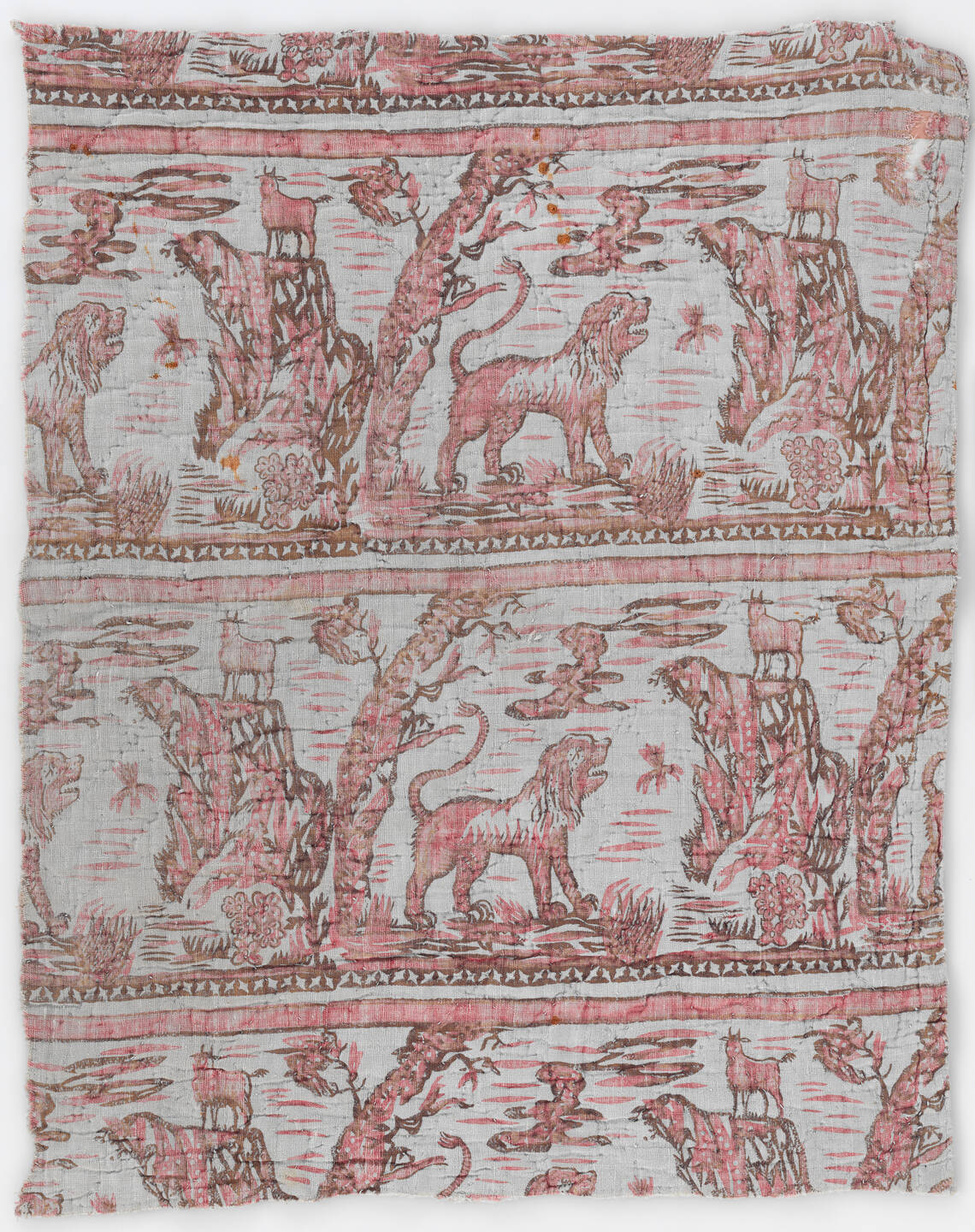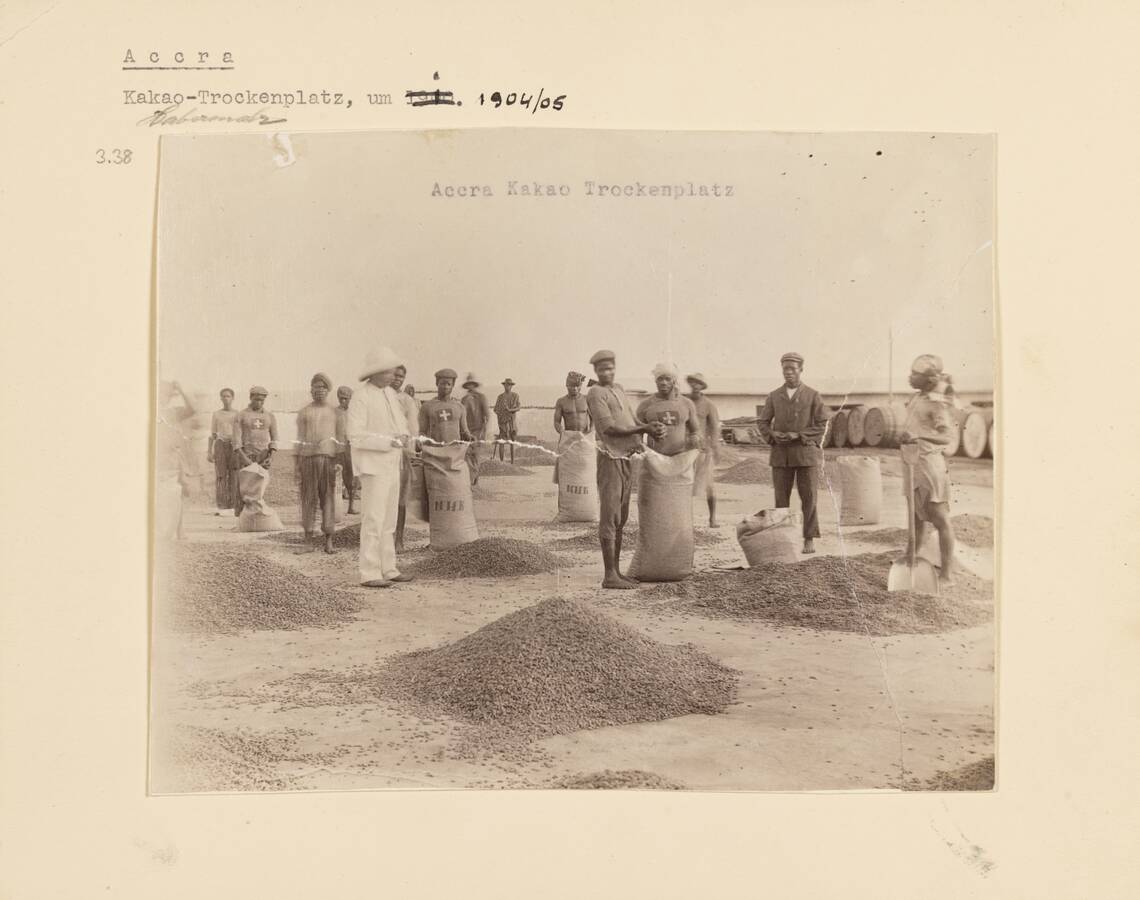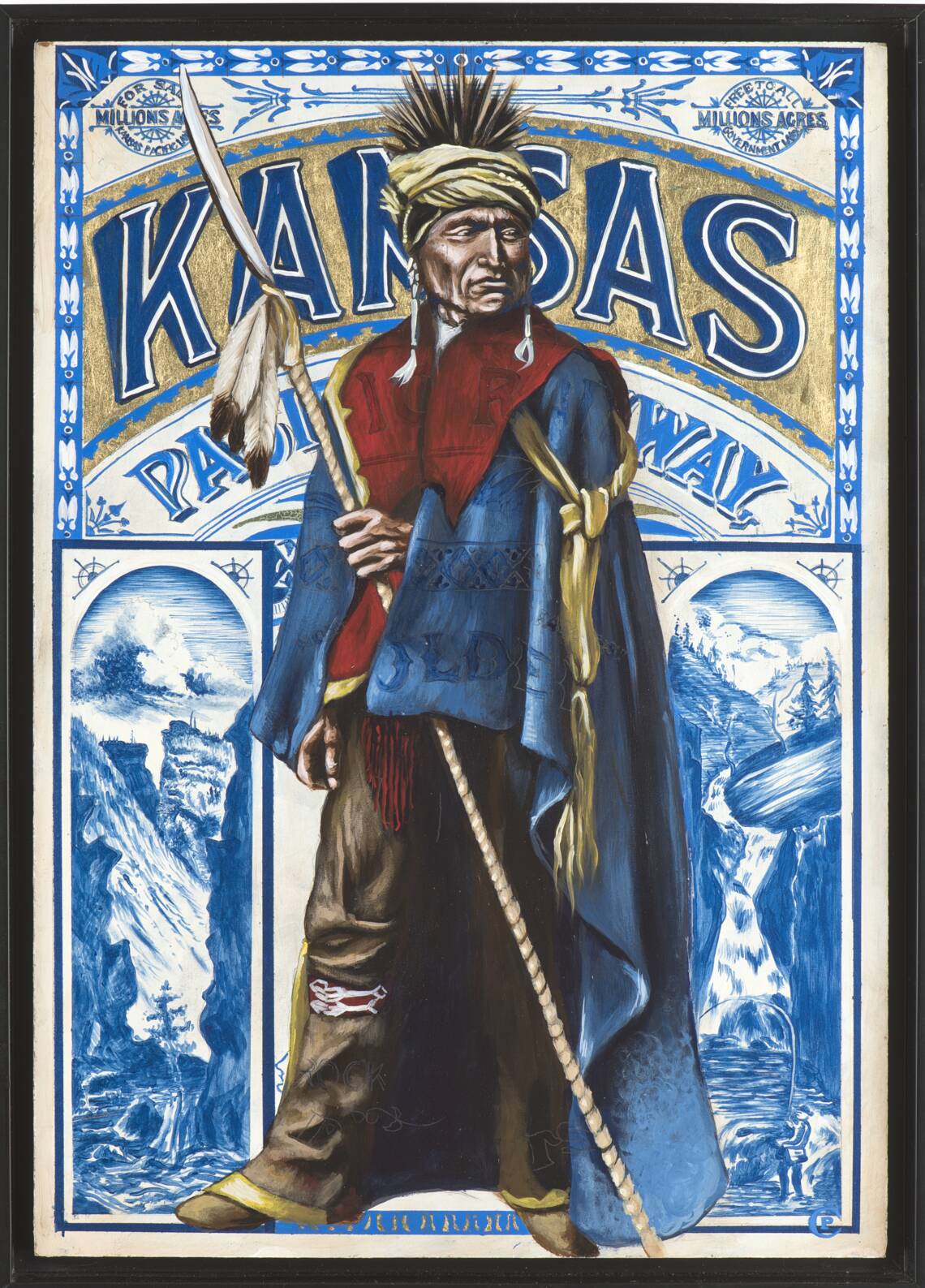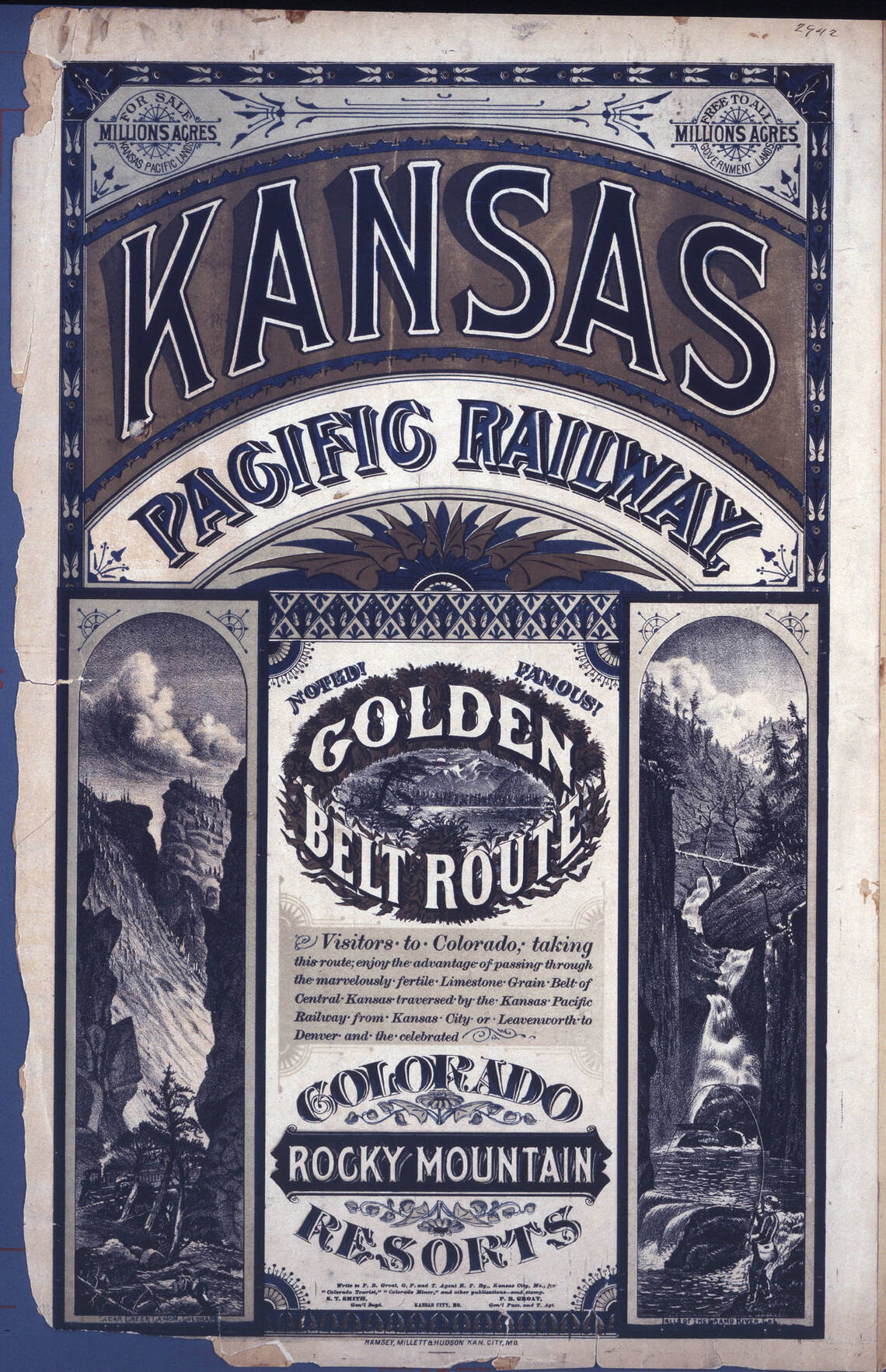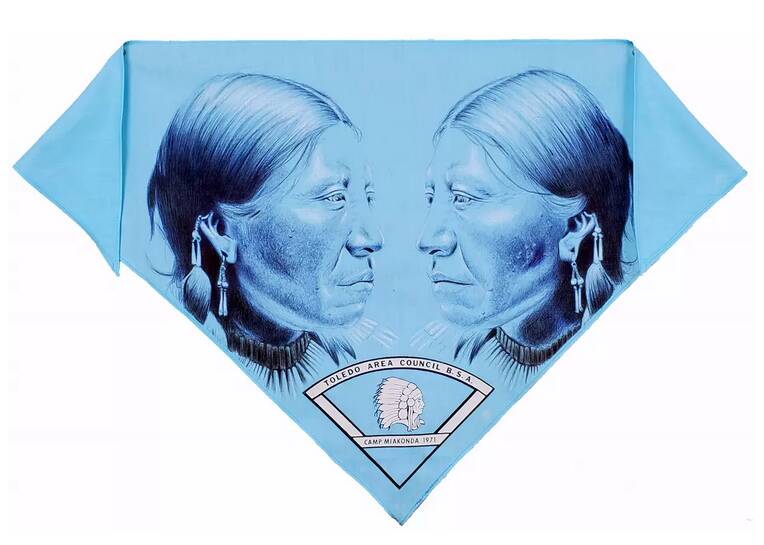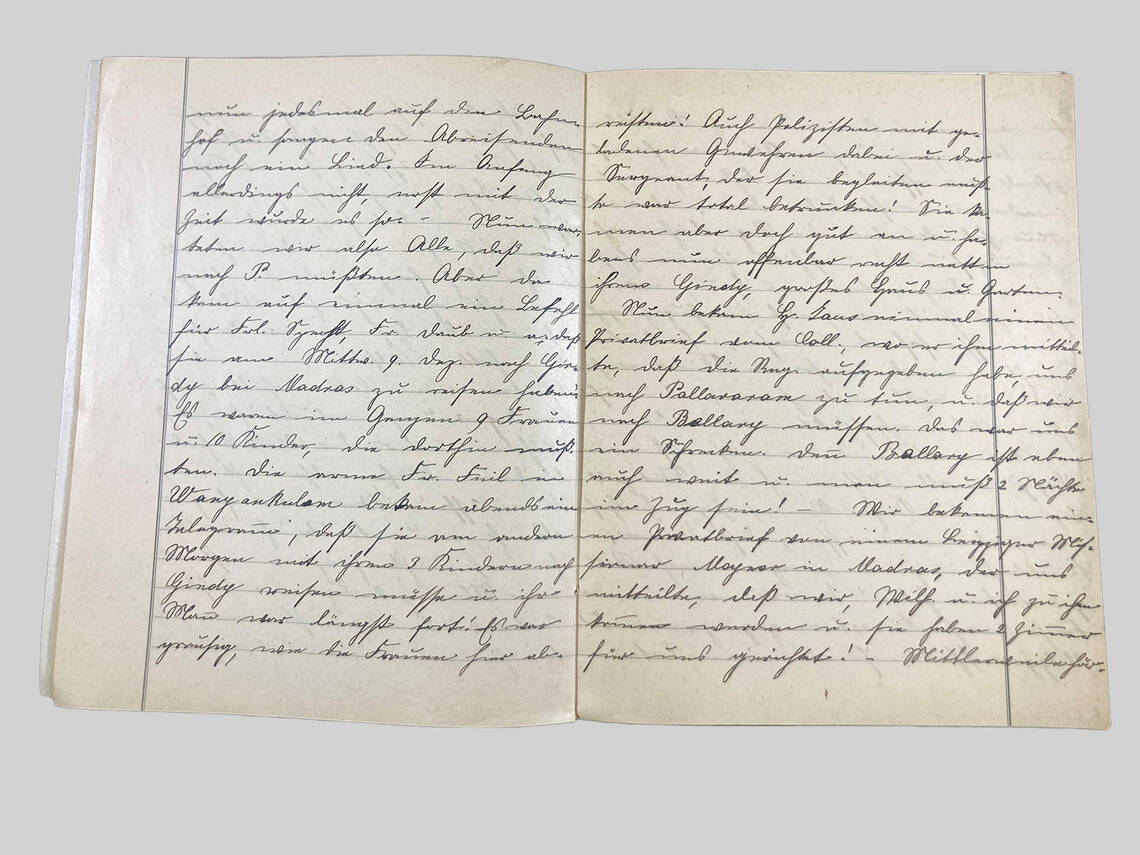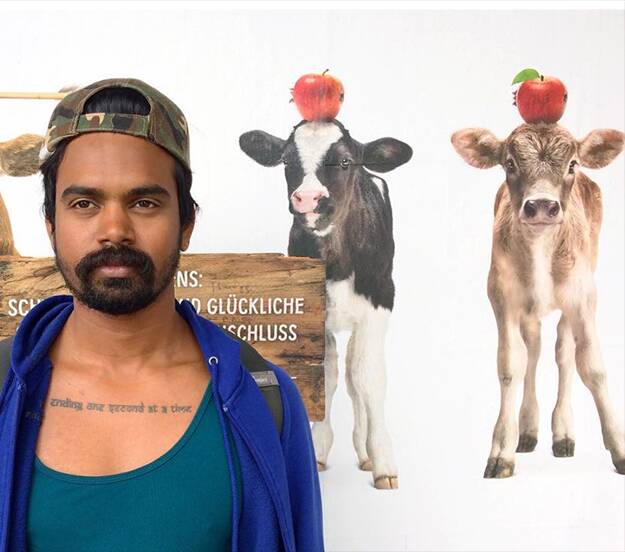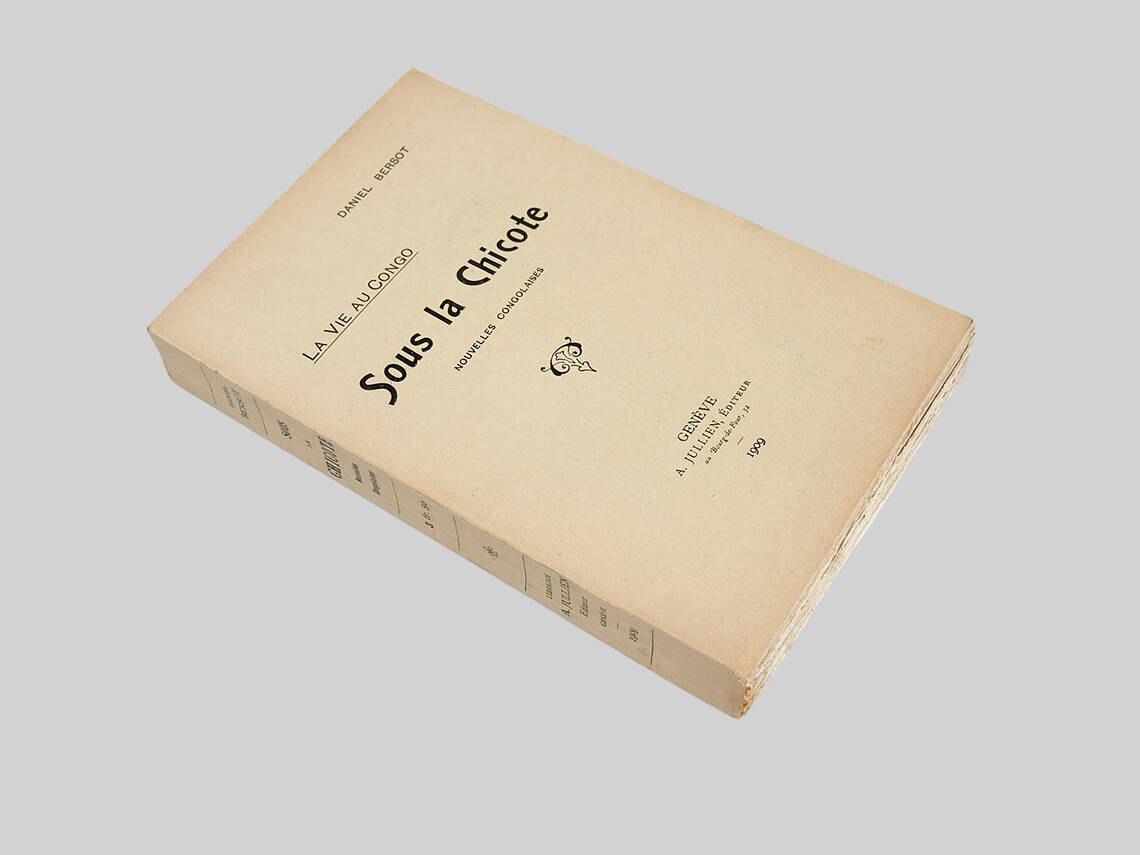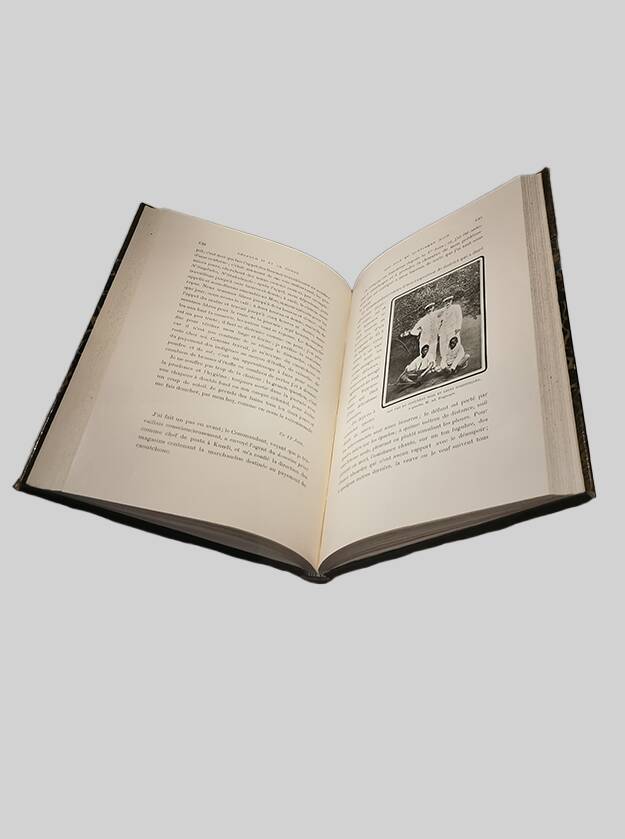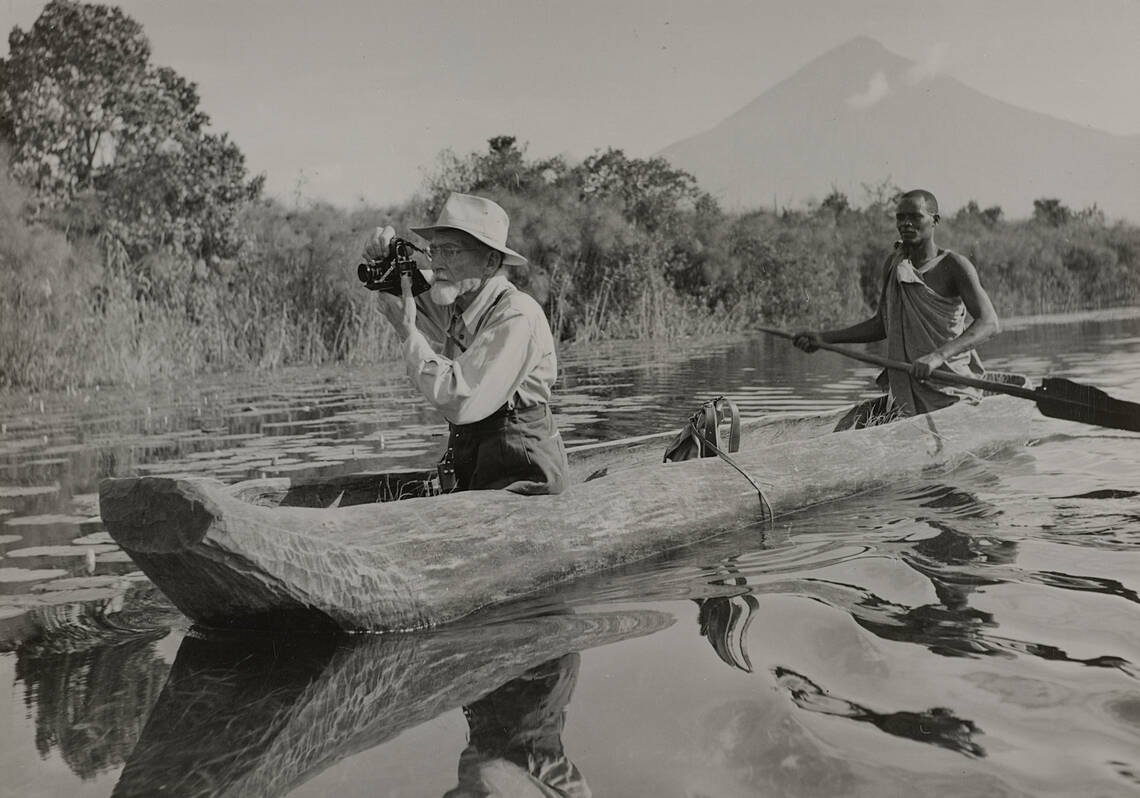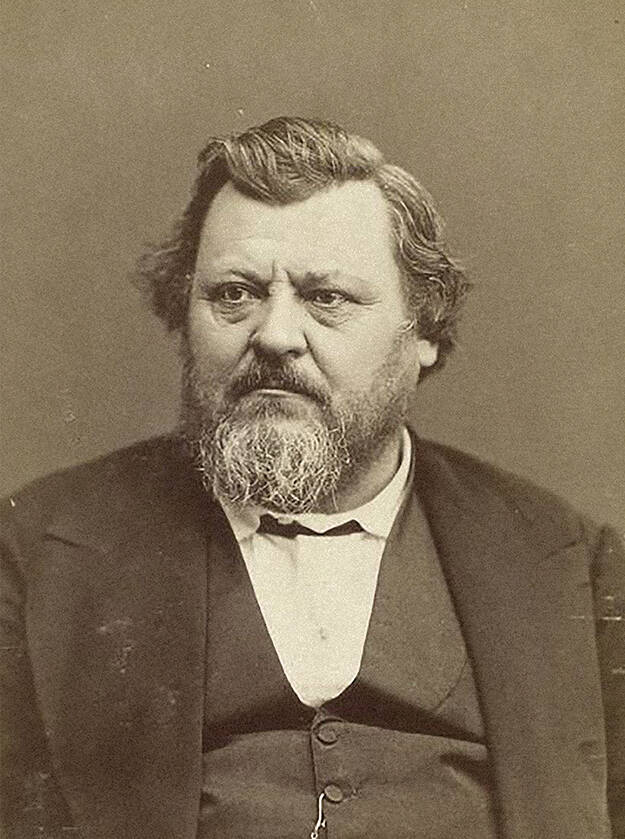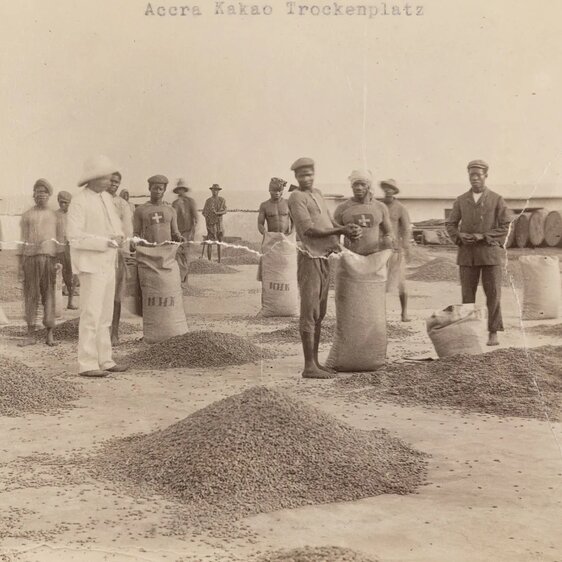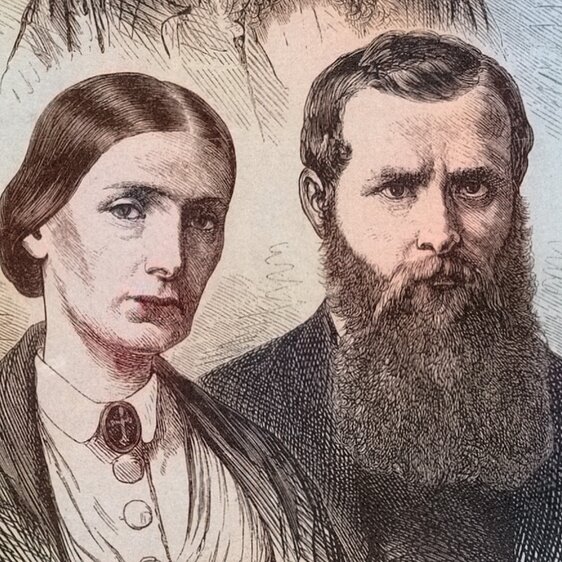-
Sabato di Kars Oggi 10:00 - 17:00
sa, Oggi
10:00 - 17:00, Sabato di Kars
-
Pasqua 20.04.2025 10:00 - 17:00
do, 20.4.2025
10:00 - 17:00, Pasqua
-
Lunedì di Pasqua (Pasquetta) 21.04.2025 10:00 - 17:00
lu, 21.4.2025
10:00 - 17:00, Lunedì di Pasqua (Pasquetta)
-
Sechseläuten 28.04.2025 Chiuso
lu, 28.4.2025
Chiuso, Sechseläuten
-
Festa del lavoro 01.05.2025 10:00 - 19:00
gi, 1.5.2025
10:00 - 19:00, Festa del lavoro
-
Giornata internazionale dei musei 18.05.2025 10:00 - 17:00
do, 18.5.2025
10:00 - 17:00, Giornata internazionale dei musei
-
Ascensione 29.05.2025 10:00 - 17:00
gi, 29.5.2025
10:00 - 17:00, Ascensione
-
Pentecoste 08.06.2025 10:00 - 17:00
do, 8.6.2025
10:00 - 17:00, Pentecoste
-
Lunedì di Pentecoste 09.06.2025 10:00 - 17:00
lu, 9.6.2025
10:00 - 17:00, Lunedì di Pentecoste
-
Festa nazionale della Svizzera 01.08.2025 10:00 - 17:00
ve, 1.8.2025
10:00 - 17:00, Festa nazionale della Svizzera
-
La lunga notte dei musei 06.09.2025 10:00 - 17:00
18:00 - 23:59
sa, 6.9.2025
La lunga notte dei musei,
10:00 - 17:00
18:00 - 23:59
-
La lunga notte dei musei 07.09.2025 0:00 - 2:00
10:00 - 17:00
do, 7.9.2025
La lunga notte dei musei,
0:00 - 2:00
10:00 - 17:00
-
Knabenschiessen 15.09.2025 Chiuso
lu, 15.9.2025
Chiuso, Knabenschiessen
-
Giornata della famiglia 19.10.2025 10:00 - 17:00
do, 19.10.2025
10:00 - 17:00, Giornata della famiglia
-
22.12.2025 10:00 - 17:00
lu, 22.12.2025
10:00 - 17:00
-
23.12.2025 10:00 - 17:00
ma, 23.12.2025
10:00 - 17:00
-
Vigilia di Natale 24.12.2025 10:00 - 14:00
me, 24.12.2025
10:00 - 14:00, Vigilia di Natale
-
Natale 25.12.2025 10:00 - 17:00
gi, 25.12.2025
10:00 - 17:00, Natale
-
Santo Stefano 26.12.2025 10:00 - 17:00
ve, 26.12.2025
10:00 - 17:00, Santo Stefano
-
27.12.2025 10:00 - 17:00
sa, 27.12.2025
10:00 - 17:00
-
28.12.2025 10:00 - 17:00
do, 28.12.2025
10:00 - 17:00
-
29.12.2025 10:00 - 17:00
lu, 29.12.2025
10:00 - 17:00
-
30.12.2025 10:00 - 17:00
ma, 30.12.2025
10:00 - 17:00
-
San Silvestro 31.12.2025 10:00 - 17:00
me, 31.12.2025
10:00 - 17:00, San Silvestro
-
Capodanno 01.01.2026 10:00 - 19:00
gi, 1.1.2026
10:00 - 19:00, Capodanno
-
San Basilio 02.01.2026 10:00 - 17:00
ve, 2.1.2026
10:00 - 17:00, San Basilio